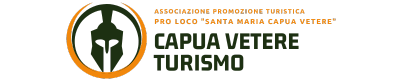L’Antica Capua
Il tesoro di Roma
Il territorio del comune di Santa Maria Capua Vetere si colloca laddove un tempo sorgeva l’antica Capua. Era qui che sorgeva l’antica Capua, come del resto attestato e confermato dai numerosi monumenti dell’epoca romana nonché dall’etimologia dell’odierno toponimo (“Capua Vetere”, da “Vetus, veteris”, aggettivo latino che significa “Antico”, dunque “Capua Antica”).
Il territorio è caratterizzato da una storia millenaria le cui prime testimonianze circa l’assetto urbano risalgono al IV° secolo a.c.. La città di Santa Maria Capua Vetere assunse il nome odierno una volta avutasi l’Unità d’Italia. Precedentemente, era stata frazione del comune di Capua con il nome di Villa Santa Maria Maggiore (Villa Sanctae Mariae Maioris), costituita da un borgo contadino sviluppatosi nei pressi della Basilica di Santa Maria Maggiore, da cui prese il nome.
Intorno al VII sec. a.C., gli Etruschi, popolazioni indigene del neolitico già residenti nella Penisola, fondarono la città di Capua. L’impianto della città era caratterizzato da un modulo ad insula che si sviluppa tra due assi principali (“cardo e decumanus”, di cui il primo era una linea retta in direzione nord-sud individuabile nell’attuale corso Garibaldi, ed il secondo era una linea che incrociava trasversalmente ad “x” la prima, individuabile anch’essa nell’attuale corso Umberto) ed altri secondari intersecantisi.
Tuttavia, nel III sec. a.C. ebbe fine il dominio etrusco sulla città per essere sostituito da quello dei Sanniti, popolazione di stirpe osca che si era stabilita nelle regioni montuose del Sannio, i quali diedero nuovo impulso alla crescita urbanistica della città, facendola diventare, per estensione, per ricchezza e per potenza, più fiorente ed attraente della città di Roma.
Nelle ricostruzioni di Capua antica fatte nel corso del XVII e XVIII secolo viene preso a riferimento il disegno fatto fare dal Cardinale Cesare Costa nel 1595. Sebbene oggi tutti concordino con il rilevare che la pianta urbana sia stata restituita con eccessiva fantasia, essa ha costituito un importante riferimento per l’individuazione e la ricostruzione di edifici e di parti della città antica.
Ad essa si rifanno le piante di Monaco del 1630, quella di G.B. Pacichelli del 1703, quella di F. M. Pratilli del 1745, e quella di F. Granata del 1752 che ne costituisce l’esatta copia. Tutte le ricostruzioni concordano nel rappresentare una città di forma all’incirca poligonale, circondata da mura in cui si aprono sei porte di accesso in città, da cui si dipartono altrettante strade extraurbane. Se ne deduce un impianto urbano basato su due assi principali orientati all’incirca secondo i punti cardinali, che si incrociano quasi ortogonalmente, e su di un asse diagonale discontinuo in direzione nord-est sud-ovest.
Nel medioevo si svilupparono tre diversi borghi. Il primo e probabilmente più importante dei tre borghi, è quello di S. Maria Maggiore, sede vescovile e luogo di scambi commerciali e culturali.
Poi il quartiere di S. Erasmo, sviluppatosi attorno alla fortezza omonima sin dal tempo del dominio svevo, che in epoca angioina divenne residenza del re Carlo durante i frequenti viaggi del sovrano d’Angiò a Capua. Il quartiere S. Erasmo è ancora perfettamente leggibile nella sua configurazione morfologica, e custodisce al suo interno formidabili testimonianze del passato.
Il terzo borgo si sviluppò attorno alla chiesa di San Pietro in Corpo, situata lungo il tratto urbano della via Appia, sulla piazzetta omonima. Le principali vie di comunicazione sono tangenti i borghi antichi, e li servono attraverso una viabilità minore a pettine.
Nel ‘700 la città si conferma importante centro militare, grazie alla posizione strategica nel territorio:
Capua, avamposto fortificato sul Volturno è a poche miglia ad ovest;
la nuova residenza reale di Caserta poco più distante, in direzione est;
le tenute di caccia di Carditello e di Calvi sono meta sempre più frequente delle visite della famiglia reale.
Sotto il regno di Carlo di Borbone, la città di Santa Maria Capua Vetere vive un grande periodo di benessere anche come centro di vita culturale. La diffusione degli ordini religiosi insediatisi in città provocarono talune trasformazioni edilizie ed urbanistiche che conferirono alla città un’impronta barocca.
Strutture settecentesche sono ancora conservate all’interno della Caserma Pica (nel rione S. Erasmo) e nella ex caserma Mario Fiore.
I tre nuclei originari (S. Erasmo, S. Maria, S. Pietro), espandendosi si sono praticamente fusi per dar vita alla città di S. Maria Capua Vetere, come viene già denominata in documenti dell’epoca.
Il borgo di S. Erasmo cresce soprattutto lungo la strada che porta a S. Maria Maggiore (via Anfiteatro, via Milbitz) e lungo il cardine romano di via R. D’Angiò. Ad est del tratto meridionale di questa, attorno allo storico luogo della fiera angioina che probabilmente era stato il foro del popolo in epoca antica, si sviluppa una compatta edilizia di bordo, che definisce chiaramente gli isolati della nuova città e la piazza Mazzini, su cui prospettano le facciate eleganti di nuovi ricche residenze.
Quella che invece attualmente si chiama via Albana costituisce un altro tratto della viabilità di impianto interessata dallo sviluppo edilizio settecentesco, probabilmente ricalcando l’asse rettilineo di un cardine romano che non era stato mai del tutto cancellato nel corso delle vicende storiche.
La pianta settecentesca riporta intorno alla città i piccoli borghi di S. Andrea, S. Secondino e Virilasci (l’antica Berelais paleocristiana nei pressi dell’anfiteatro).
Vi sono inoltre le emergenze religiose extra moenia costituite dal complesso di S. Maria delle Grazie (ex Costantiniana) e S. Agostino, ed infine le masserie più importanti a presidio del fertile territorio agricolo che aveva costituito l’Ager Campanus.
La Carta del Regno di Napoli del 1836, e la Carta dei dintorni di Napoli del 1836 – 1840, propongono un’esauriente rappresentazione dell’evoluzione sopravvenuta dell’agglomerato urbano. Si individua con chiarezza la stazione ferroviaria, la sopravvenuta edificazione lungo l’asse della Via Albana con unità edilizie a corte ed in linea; l’avvio del processo di edificazione lungo il fronte occidentale.
La cartografia IGM del 1880 nella scala 1:50.000 costituisce un importante documento per studiare l’evoluzione urbanistica di S. Maria C.V. in un periodo di grandi trasformazioni ed avvenimenti.
Successivamente all’unificazione, si impone all’attenzione la borghesia urbana industriale, che si esprime con la localizzazione di significative attività (concerie, canapifici, tabacchifici).
Il settore pubblico d’altra parte rafforza gli interventi nelle opere pubbliche di bonifica, intraprendendo nello spazio urbano la costruzione di importanti edifici, quali il tribunale, il liceo, il teatro, il palazzo municipale.
L’adeguamento della città ai valori simbolici posti dalla nuova domanda sociale trova adeguato segno anche a S. Maria C.V. Si operò infatti il rinnovo del tessuto insediativo centrale, attuato attraverso lo sventramento volto alla formazione del Corso Garibaldi. L’intervento di sventramento ed il correlato reimpianto avviano un processo di densificazione urbana, continuato fino agli anni novanta. L’espansione edilizia lungo la viabilità di impianto interessò tutti i Casali, ormai saldamente fusi in un unico agglomerato.
Gli isolati compresi tra via Anfiteatro, via D’Angiò, corso Garibaldi, via Albana, nuova ferrovia Roma-Napoli, risultano in planimetria già intensamente urbanizzati.
Si intravede dalla rappresentazione cartografica l’inizio dell’urbanizzazione delle aree ad ovest e sud-ovest del centro cittadino, che daranno vita a quel compatto e coerente tessuto formato dalle dimore a “corte operaia” che caratterizzano il tessuto urbanistico della parte di città.
La planimetria IGM 1907 aggiorna la situazione soprattutto per quanto riguarda le infrastrutture su ferro. Oltre alla ferrovia dello Stato, è bene evidente la tratta della ferrovia Alifana che, provenendo da sud lungo la via per Aversa, si biforca in prossimità di S. Andrea: la tratta ovest si ferma subito a sud della stazione FS, con degli edifici di servizio per la manutenzione; la tratta orientale circonda S. Maria e presenta due stazioni in prossimità del nuovo riformatorio (ex S. Pasquale) e dell’attuale “Incremento ippico” in via Caserta.
Con la carta IGM 1957 si fornisce il quadro della città che la storia ha plasmato. I quartieri operai occidentali si sono configurati in modo compiuto ed i due bracci della ferrovia Alifana ne segnano nettamente i confini ad est e ad ovest, quasi a volersi ispirare alle mura urbiche antiche. L’evoluzione urbanistica intercorsa nei decenni post bellici hanno portato allo sviluppo, in senso industriale, di quelle attività di lavorazione dei prodotti agricoli, come la concia delle pelli, la lavorazione della canapa e del tabacco, che erano state caratteristiche, assieme alle funzioni terziarie, della vita economica e produttiva cittadina.
La planimetria aggiornata al 1980 evidenzia con grande efficacia il processo di densificazione subito dal centro cittadino, la crescita estensiva della periferia urbana e la localizzazione di nuove attività industriali gravitanti attorno all’impianto industriale “Siemens” ubicati a sud della via Appia.
Negli ultimi decenni, rispondendo alle logiche di uno sviluppo inteso in senso meramente quantitativo, la costruzione o ricostruzione di edifici sui margini stradali, hanno portato all’estinzione quasi totale della tipica corte agraria urbana, caratterizzata da un’edilizia a cortina sulla viabilità di impianto e da altezze sempre contenute entro i due o tre livelli fuori terra.
I nostri siti:
Anfiteatro Campano;
Arco di Adriano;
Castellum Aque;
Catabulum;
Criptoportico;
Domus di Confuleio;
Domus di via Bonaparte (Ninfeo);
Domus di via degli orti;
Mitreo
Anfiteatro Campano è il punto di riferimento principale del Comune di Santa Maria Capua Vetere. “Esso è sito in piazza I° Ottobre 1860, costruito tra la fine del I e gli inizi del II secolo dopo Cristo in una posizione strategica, vicino alla via Appia e al decumano maggiore della centuriazione.
Abbellito dall’imperatore Adriano con statue e colonne e inaugurato dall’imperatore Antonino Pio nel 155 d.C., fu devastato dai barbari nel 841. Adibito successivamente a fortezza, divenne in età medievale e rinascimentale una vera e propria “miniera” di materiali di costruzione, subendo spoliazioni di marmi, colonne e ornamenti. Fu Francesco I di Borbone a porre fine allo scempio con un editto datato 1826. L’Anfiteatro Campano si sviluppa su tre piani con arcate decorate da statue e un quarto a parete continua. L’edificio poteva ospitare fino a 60mila spettatori, ai quali i posti erano assegnati in base all’ordine sociale. Senatori e magistrati godevano di una visuale migliore; alle donne era riservata la “cathedra”.
Nell’arena si svolgevano combattimenti tra gladiatori e spettacoli con animali (leoni, orsi, tori, elefanti). Attraverso le botole, ancora oggi visibili, venivano innalzati oggetti scenici come rocce o colonne. Oltre a un consistente avanzo dei due piani inferiori, sono giunti a noi in ottimo stato i sotterranei, che rappresentano il luogo più suggestivo da visitare. Qui, attraverso una rampa, venivano trasportati gli animali poco prima di entrare nell’arena. Erano, inoltre, dotati di una vasta cloaca a croce per lo scolo delle acque. I canali convogliano il liquido contenuto in una cisterna, utilizzato per la pulizia dei sotterranei stessi e dell’arena, nelle fognature poste a nord e sud dell’Anfiteatro. L’edificio, secondo per dimensioni solo al Colosseo di Roma, è a pianta ellittica: l’asse maggiore è lungo 167 metri, quello minore 137. Gli archi dei tre piani inferiori erano costituiti da ottanta arcate ornate da busti di divinità (alcuni furono distrutti, altri riutilizzati, altri ancora sono esposti nei musei). Si conservano solo due archi sulle cui chiavi vi sono protomi raffiguranti Giunone e Diana. All’esterno della struttura sono sistemati sepolcri sui quali sono presenti tracce degli affreschi che li decoravano. Nello stesso luogo, in età repubblicana, sorgeva il primo Anfiteatro, antecedente a quello oggi visibile, nel quale aveva combattuto il gladiatore Spartaco, capo della rivolta servile nel 73 a.C.; si tratta del più antico anfiteatro d’Italia costruito in piano e del quale sopravvivono pochi resti visibili. In particolare, scavi in proprietà privata de Paolis hanno evidenziato resti delle gradinate
“L’Arco di Adriano, comunemente definito “Arco di Capua”, sito in via del Lavoro (antica Via Appia) è un arco di trionfo originariamente a tre fòrnici, delle quali restano quella di sinistra, ancora integra, e un pilastro della centrale. L’Arco, alto circa 10 metri, risale al II secolo d.C. e, da una lapide rinvenuta nel 1700, si deduce che fu dedicato ad Adriano; pare, infatti, che l’imperatore amasse soggiornare a Capua per il clima dolce e lo splendido paesaggio. Alcuni studiosi, tuttavia, attribuiscono l’arco a Traiano, che volle la ristrutturazione della via Appia. Il monumento era un tempo rivestito di lastre di marmo e ornato da statue poste nelle nicchie. Su una lapide collocata nel 1863 sono incise le parole dettate dal patriota
Luigi Settembrini per ricordare la “battaglia del Volturno”, combattuta il primo ottobre 1860 Al Ponte San Prisco, in via Caserta, si incontrano i resti di una costruzione alta circa 4 metri: si tratta del Castello dell’Acquedotto Romano Castellum Aquae: avanzi di mura di fortificazione di età preromana, di una delle Porte che immettono sull’Appia in direzione di Benevento e degli avanzi di una Cisterna di accumulo dell’Acquedotto che, in età augustea, portava acqua dal Taburno a Capua.
“Il Catabulum, o Catabolo, sito nella traversa Convento delle Grazie, è uno dei più misteriosi reperti di epoca romana,ritenuto il recinto delle fiere destinate agli spettacoli nell’Anfiteatro, ma più verosimilmente si tratterebbe dei resti di un edificio termale
“Il Criptoportico”, di epoca romana, si trova in piazza S. Francesco, nell’ex sede della Facoltà di Lettere e Filosofia. Era frequentato per le passeggiate al coperto e, composto da due piani (l’inferiore dei quali sottoposto al piano di calpestio della città), accessibile tramite rampe di scale. Era costituito da tre bracci (quello settentrionale misurava 96,80 metri e quelli est e ovest 79,60 metri; larghi circa 7 metri e alti 10 metri, con pavimenti a mosaici.
“La Casa di Publius Confuleius Sabbio fu scoperta lungo corso Aldo Moro nel 1955. Due gli ambienti rinvenuti, risalenti al I sec. a.C.: dalla scala antica rivestita in mattoni si giunge al primo dei due vani che presenta nella decorazione pavimentale la suddivisione tipica dei triclini (sale da pranzo). All’ambiente più interno si accede attraverso un passaggio ad arco nel cui pavimento è la scritta “Recte omnia/velim sint nobis” (Vorrei che tutte le cose ci vadano bene). Sulla soglia del secondo vano si trova l’iscrizione “P.Confuleius P.M.I. Sabbio Sagarius/domum hanc ad solo usque ad summum/fecit architecto T. Safino T. F. Fal.
Pollione” (Publio Confuleio Sabbione, liberto di Publio Marco, venditore di mantelli, fece questa casa dalle fondamenta alla sommità, essendo l’architetto Tito Safinio Pollione, figlio di Tito della Tribù Falerna). La presenza della vasca e del pozzo nel primo ambiente fanno pensare che qui si svolgesse una fase della lavorazione del “sagum”, il pesante mantello di lana dei soldati, usato nel tipo più grezzo da poveri e schiavi.
“Il Ninfeo di una lussuosa domus romana, con al centro una grande vasca con fontana troncopiramidale, abbellita con scalette e mosaici, è incastonato nel portico di un edificio moderno,
“La Domus Imperiale di via degli Orti è un complesso abitativo signorile del tardo Impero. Scavi effettuati negli anni Sessanta hanno portato alla luce gli ambienti di rappresentanza, organizzati intorno a un giardino. Un ninfeo fa da sfondo scenografico ai reperti “Scoperto nel 1922, il Mitreo è del II sec.d.C., quando il culto orientale del dio Mitra ebbe la sua massima diffusione in tutto l’Impero Romano; si tratta di uno dei pochissimi e meglio conservati templi dedicati al dio Mitra in tutta Europa. Presenta un vestibolo e una sala con sedili laterali (riservati agli adepti) al di sopra dei quali alcuni affreschi illustrano i sette gradi di iniziazione. La volta è dipinta con stelle a otto punte verdi e rosse. Sulla parete di fondo si può ammirare l’affresco, straordinariamente ben conservato, che ritrae Mitra nell’atto di uccidere un toro bianco. Agli angoli del dipinto, il Sole, la Luna, l’Oceano e la Terra “assistono” al sacrificio. Completano la scena un corvo, un serpente, un cane, uno scorpione e due portatori di fiaccole, che simboleggiano il sorgere e il tramontare del sole. Mitra, infatti, era concepito come potenza benefica connessa con la luce.
I palazzi del centro storico
Palazzo Melzi
Sede dell’attuale facoltà di Giurisprudenza dell’Università Luigi Vanvitelli

Palazzo Teti-Maffuccini
Dove fu firmata la resa dei Borboni insieme a Garibaldi

Palazzo Mazzocchi
L’antichissimo palazzo privato